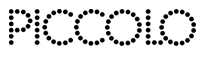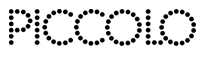Diario di prove dello spettacolo da gennaio ad aprile 1974.
Riflessioni su Cecov, sul testo e sulla sua interpretazione.
Diario di prove del Giardino dei ciliegi
14 GENNAIO 1974
Nella camera dei bambini del 1° atto ci sono "le cose" che appartenevano all’infanzia di Liubov e Gaiev. Le battute di Liubov non lasciano dubbio in proposito. L’indicazione di Cecov è: la camera che è "ancora" chiamata la camera dei bambini. E in quell’"ancora" è racchiuso, con estrema densità, il senso che probabilmente Cecov voleva dare a tutto l’ambiente-scena-racconto-situazione.
La chiamano "ancora" dei bambini, quella stanza, ma non è più dei bambini, perché "bambini" non ce ne sono: l’ultimo è morto cinque anni prima ed era il bambino di Liubov. Ania ha "la sua stanza", anche se è ancora quasi bambina, ma l’infanzia vera e propria è finita in quella stanza, appartiene al passato. In realtà la stanza era solo quella dei bambini Gaiev e Liubov.
Così credo sia necessario individuare alcune "cose" tipiche rimaste: cioè plausibili ma che abbiano la stessa risonanza della "didascalia". Infatti se noi osserviamo le "scene" delle diverse edizioni del Giardino da quella del 1904 all’ultima di Visconti, tra le quali c’è anche quella di Giorgio Strehler, in tutti i paesi, compresa la Cecoslovacchia, che sembra abbia oggi un poco il monopolio della "riscoperta" di un Cecov "diverso" da Stanislawskij, ci accorgiamo che se non lo si dice, nessuno può capire che quella "era" ed "è" nonostante tutto la camera dei bambini.
Si vede una "stanza" qualsiasi, più o meno ben fatta, più o meno realistica o semplicizzata ma il sentimento plastico dell’infanzia non c’è. È probabile che la stanza sia stata usata, nel tempo, dopo i bambini, come camera di passaggio. Infatti i personaggi passano, entrano quasi per caso nella stanza. Liubov dorme altrove, Gaiev anche, Ania pure.
La stanza non serve più. E può essere una specie di vasta anticamera spoglia ma che porta la traccia dei bambini di un tempo. Qualche mobile rimasto immobile, mentre i bambini sono diventati vecchi. Due banchi di scuola, piccoli, dipinti di bianco. Là, i "bambini", fratello e sorella, facevano i compiti, un tavolino laccato, nano, e qualche seggiolina e due poltroncine per un salottino "da gioco". Uno scaffale con la lanterna magica a petrolio e qualche giocattolo restato lì, per caso. E un servizio per giocare alla cucina o al "pranzo" di Liubov. Una piccola bilancina di latta per "giocare al commercio", la credenzina con i cassettini per le spezie e un servizio da caffè e tè, minuscolo. Ma c’è anche un divanone per grandi. E c’è un armadio - mamma, da un lato, grandissimo, bianco a specchio dentro, semplice, ma misterioso.
Gaiev e Liubov ritroveranno a poco a poco la loro infanzia perduta non "soltanto" guardando il giardino nell’alba. Ma vivendo tra i fantasmi rimasti di un’infanzia sepolta. Finiranno anche per sedere nei banchi, a malapena, rannicchiati e parlarsi così. Gaiev si sporcherà le dita d’inchiostro come una volta e Liubov peserà lo zucchero con la bilancina e verserà un po’ di tè o caffè nelle tazzine e giocherà con se stessa e con Gaiev, servendo tutto su una guantierina di latta dipinta. Sederanno anche intorno al tavolino nano, per un gioco impossibile che culminerà con lo spalancarsi dell’armadio che incautamente Gaiev avrà battuto e poi aperto girando la chiave, nel suo sermone sul passato.
Perché dentro l’armadio c’è troppa roba stipata, alla rinfusa che precipiterò in scena come una tenera e lancinante valanga, con polvere e strass e piume e cappelli e veli e nastri e scarpe e scatole e marinarette blu e tanto tanto altro, scatole con palle di natale che rotolano e poi si rompono, carte e lettere e infine la carrozzina cromata di tela cerata nera, come una piccola bara che correrà da destra a sinistra, sull’avanscena per poi investire Liubov ignara ancora che si trova la carrozzina del suo bambino, addosso.
E allora, là Liubov piangerà in silenzio. E la stanza apparirà allora come una specie di cimitero del tempo in cui invano Varia e anche Liubov e Gaiev poi durante una parte della scena tenteranno di mettere ordine. Senza riuscirci. Forse finiranno per sedersi per terra sui vecchi vestiti, cappotti e una coperta di pelo, una volta bellissima, ora smunta ma ancora morbida da accarezzare e farvisi su dentro. E Ania si addormenterà così o in mezzo a tanto passato, anche lei a terra, dolcemente o su un banco piccolo di scuola, senza accorgersi quasi e si farà portar via così, mentre la luce invade quel terribile e dolce vuoto.
15 GENNAIO
Il Primo Atto: la camera dei bambini, i mobili da bambini, i banchi di scuola, dove Gaiev e Liubov hanno fatto i compiti, e il grande armadio-mamma-memoria, pieno di tutta una vita, o tante vite. La carrozzina nera, di tela cerata e cromata, del bambino morto, che rotola fuori per prima quando Gaiev nella sua predica batte l’armadio con le mani e ne apre le ante. Dall’armadio esce la carrozzina che traballando rotola e si ferma dalla parte opposta vicino a Liubov, e scendono, precipitano fuori valanghe di cose, scarpe, un abito da marinaretto con cappello coi nastri, e impermeabili, e mantelli, e sacchi, e libri, e fogli di carta, e cappelli, e tanto altro: il cimitero delle vite che passano.
Nel Secondo Atto: un fondale, lontano, e il trenino-giocattolo che percorre il fondale da una parte all’altra, poi esce in quinta e rientra alla ribalta, rientra in quinta e riappare nel fondale, con piccole luci e vagoni di latta e la carica meccanica, e traballa a metà tra giocattolo e memoria anche lui, e finzione. Quando passa nel fondo, quasi invisibile, tra le montagne del fondale meravigliosamente dipinte, o la pianura meravigliosamente dipinta. I protagonisti giocano e non giocano ancora con l’oggetto dell’infanzia, in un vuoto ove le parole risuonano ... Sull’avanscena, il mistero di quel giardino che non c’è e scende fino in platea. Un sipario di luce attraverso il quale si vede tutto lo spettacolo.
Un’atmosfera luminosa, mobile, impalpabile; e nello stesso tempo quasi densa, di polvere e sole e luna e vento, che muta e diventa notturna, e alba, che diventa ora lirica, ora tragica e cupa. Se un telo grande e semplice scendesse dal palco giù nella platea, come steso su un terreno morbido, un ondeggiare di colline (forse il monte verde e scuro dei Giganti), portato davanti e fin giù ...
21 GENNAIO L’idea di Cecov di far svolgere il primo e l’ultimo atto del Giardino nella "camera dei bambini" non è casuale. Né lo è l’armadio, in quella stanza. È strano che nessuno abbia mai dato l’importanza che merita a questa evidente figura-simbolo: l’armadio di cent’anni. A mio avviso l’idea dell’armadio, oggetto reale e plastico, e simbolo appunto, integra perfettamente l’idea della "camera dei bambini", e cioè dei giochi di una età ormai favolosa per i "vecchi". Proietta nella camera dei bambini (oggetti, cose) un altro oggetto-cosa che prolunga il tempo della stanza. Cioè, nella stanza dei bambini ci sono dei vecchi, e nella stanza c’è anche una cosa ancora più vecchia, che rimanda ancora più indietro, ancora più indietro di Firs che è il più vecchio.
L’armadio è qualcosa di intermedio fra la gente che agisce e il giardino, vero e presupposto o simbolico, che è antichissimo. Il gioco del tempo viene così potenziato dall’armadio e ancora non è un caso che Gaiev faccia quel lungo discorso proprio all’armadio. I due termini, insomma, sono in una posizione plastico-dialettica di enorme efficacia, purché di questo armadio si riesca a fare qualcosa di più di una presenza relativa.
Non dimentichiamo che Cecov, ad esempio, dice in didascalia: "Varia apre l’armadio, che scricchiola".
Cecov non scrive mai una didascalia a caso. Qui c’è dunque un’indicazione comica, di una cosa "antica", penosa, che fa fatica, che evoca il senso del tempo, e tanto altro.
29 GENNAIO Il problema del "giardino" è fondamentale. Nessuno di noi è riuscito mai a rendere poeticamente, simbolicamente e plasticamente questo giardino, che rappresenta forse troppe cose insieme per poter essere "rappresentato", almeno sulla falsariga del naturalismo poi diventato realismo "poetico". Le strade scelte o tentate di Svoboda e altri, cioè di una astrazione simbolica non solo del giardino, ma di tutte le scene e di tutto Cecov, hanno certo ottenuto talvolta risultati interessanti ed anche pregnanti poeticamente. Ma il problema è stato, per così dire, aggirato.
Nonostante tutto, quando il vecchio Pitoeff rappresentava il Giardino in un panorama di velluto grigio con pochi mobili, e diceva che Cecov era solo "atmosfera di parole", faceva la stessa operazione, con maggiore ingenuità ma anche con minore presunzione. In realtà, noi oggi stiamo rendendoci conto che bisogna tentare di rappresentare Cecov non sulla falsariga di Stanislawskij (e fu nostro compito conquistare questa dimensione), ma su un altro versante: quello più universale-simbolico, più aperto a sollecitazioni fantastiche; con il terribile pericolo di ricadere in una specie di astrazione tutto fare, di togliere "ogni significanza" alla realtà plastica di Cecov, cioè alle cose: che sono stanze, tavoli, sedie, finestre, cose, e insomma soprattutto storia.
Perché la storia è "vista" dallo spettatore come ambiente, e come costumi e visi e capelli e occhiali e colletti e altro. Occorre ovviamente anche il resto, e cioè la storia dentro le cose e nei personaggi. Ma isolare un atto di Cecov in una "scena astratta", in un vuoto simbolico, è togliere "realtà" plastica alla storia. È come dire che questo si svolge oggi e sempre.
Ora, il problema di Cecov è sempre quello che io chiamo delle "tre scatole cinesi". Ci sono tre scatole: una dentro l’altra, a stretto contatto, l’ultima contiene la penultima, la penultima la prima. La prima scatola è la scatola del "vero" (del possibile vero che in teatro è il massimo vero), e il racconto è un racconto umano, interessante. Non è vero, ad esempio, che il "Giardino" non ha una trama "divertente". È anzi pieno di colpi di scena, pieno di avvenimenti, di trovate, di atmosfere, di caratteri che mutano.
È una storia umana bellissima, è un’avventura umana emozionante. In questa prima scatola si racconta dunque la storia della famiglia di Gaiev e di Liubov, e di altri. Ed è una storia vera, che si colloca certo nella storia, certo nella grande vita, ma il suo interesse sta proprio in questo suo far vedere come vivono davvero i personaggi, e dove vivono.
È un’interpretazione-visione "realistica", simile ad una ottima ricostruzione come la si potrebbe tentare in un film di atmosfera. La seconda scatola invece è la scatola della Storia. Qui l’avventura della famiglia è vista tutta sotto l’angolatura della storia, che non è assente nella prima scatola, ma ne costituisce il sottofondo lontano, la traccia quasi invisibile.
Qui invece la storia non è solo "costume" o "oggetto": è lo scopo del racconto. Qui interessa di più il muoversi delle classi sociali in rapporto dialettico tra di loro. Il mutamento dei caratteri e delle cose come passaggi di proprietà. I personaggi sono certo loro stessi "gente umana", con precisi caratteri individuali, certi vestiti, e certi visi, ma rappresentano – in primo piano – una parte della Storia che si muove: sono la borghesia possidente che sta morendo di apatìa e di assenza, la nuova classe capitalistica che sale e si impadronisce, la nuova giovanissima imprecisa rivoluzione che si annuncia, e così via. Qui stanze, oggetti, cose, vestiti, gesti, pur mantenendo il loro carattere plausibile sono come "spostati" un poco, sono "straniati" nel discorso e nella prospettiva della Storia.
Indubbiamente la seconda scatola contiene la prima, ma appunto per questo è più grande. Le due scatole si completano.
La terza scatola è infine la scatola della vita. La grande scatola dell’avventura umana; dell’uomo che nasce, cresce, vive, ama, non ama, vince, perde, capisce non capisce, passa, muore. È una parabola "eterna" (per quanto di eterno possa esserci nel breve corso dell’uomo sulla terra). E qui i personaggi sono visti ancora nella verità di un racconto, ancora nella realtà di una storia "politica" che si muove, ma anche in una dimensione quasi "metafisica", in una sorte di parabola sul destino dell’uomo.
Ci sono i vecchi, ci sono le generazioni di mezzo, ci sono i più giovani, ci sono i giovanissimi, ci sono i padroni, i servi, i mezzi padroni, la tizia del circo, l’animale, il ridicolo, e via dicendo, c’è una specie di paradigma dell’età dell’uomo e degli uomini.
La casa è "La casa" e le stanze sono "Le Stanze dell’uomo" e la storia diventa una grande parafrasi poetica da cui non è assente il racconto, non è assente la storia, ma è tutta contenuta nella grande avventura dell’uomo in quanto uomo, carne umana che passa. Questa ultima scatola porta la rappresentazione sul versante "simbolico e metafisico allusivo", non so trovare la parola esatta. Si decanta di molto aneddoto, diventa molto più alta, si libra molto più in su.
Ogni scatola ha dunque la sua fisionomia e il suo pericolo. La prima il pericolo della minuzia pedante, del "gusto" della ricostruzione (molto Visconti) e del racconto visto dal "buco della serratura" e che si ferma quasi lì. La seconda ha il pericolo dell’isolare i personaggi come emblemi di storia, cioè raggelati in una posizione di pesi o di tematica storica (Marx, critica a Schikingen, Lassalle, e via dicendo: ad esempio, lo "schillereggiare") cioè di togliere umanità vera ai personaggi per ergerli a simbolica storica.
Il vecchio studente non più "vecchio studente" perché è così, ma perché la Storia vuole che ci sia un vecchio studente, rappresentante di una parte oppressa, vecchio anzitempo perché ha sofferto forse anche il carcere, rappresentante del mondo nuovo che sale con incertezze e sussulti: è l’avvenire, c’è qualcosa di eroico e di positivo in lui, molto più che di negativo. E Liubov e Gaiev sono teneri dilapidatori, ma anche "viziosi"; sono i simboli di una classe decaduta (in una edizione cecoslovacca Liubov si faceva palpare le cosce sotto le sottane dal servo lascia. E Duniascia – altro esempio – nell’ultima atto era vistosamente incinta, così via; qui magari in ossequio al pan-erotismo attuale, senza il quale non si fa teatro moderno!).
La scena è ancora quella di prima, ma già più trasposta, più segnata come ambiente forse precario, vecchio e cadente a pezzi, e altro. La terza ha il pericolo di diventare solo "astratta". Solo metafisica. Fuori quasi del tempo. Ambiente neutro. Un teatro coperto da un fondale di un certo colore, con alcune cose dietro. (Ritorniamo a Pitoeff, magari con i trucchi di materia di Svoboda: non cambia). I personaggi qui sono vestiti, certo ma appena "nel tempo": essi tentano piuttosto di diventare emblemi universali, non so attraverso quali mezzi o metodi. Ma comunque tutta la rappresentazione diventa astratta, simbolica, universale perdendo il peso quasi terreno. Ora, Il giardino dei ciliegi di Cecov è "tutte e tre le scatole", una dentro l’altra. Insieme.
Perché ogni grande poeta di ogni tempo si muove, quando è veramente poeta, sui tre piani contemporaneamente; e questi tre piani possono essere scissi solo per gioco o per studio, come l’entomologo che seziona un essere vivente per studiarne alcune caratteristiche sotto vitro.
Perché l’essere vive, non è afferrabile nel suo movimento e non è riconducibile ad una delle sue caratteristiche. Bisogna prenderlo tutto insieme, per saperlo. I poeti sanno, e ci danno figure eterne e contingenti, la storia dialettica (rivoluzione e reazione, mondo vecchio e mondo nuovo) e la storia dell’avventura umana che è anch’essa tutto, piccola cosa che significa solo sé stessa e il suo amore o dolore o gioia, e al tempo stesso Storia, membro irriducibile ad altro di un suo contesto sociale, e nello stesso tempo "essere umano" che porta avanti questa cosa strana, profonda, misteriosa; sì certo, anche misteriosa, che è la vita dell’uomo, dal primo giorno a quello che sarà l’ultimo. Una rappresentazione "giusta" dovrebbe darci sulla scena le tre prospettive unite insieme, ora lasciandoci vedere meglio il moto di un cuore o di una mano, ora facendoci balenare davanti agli occhi la storia, ora ponendoci una domanda sul destino di questa nostra umanità che nasce e deve invecchiare e morire, nonostante tutto il resto, Marx compreso. Una scena "giusta" dovrebbe essere capace di vibrare come una luce che si muove alle tre sollecitazioni...
6 FEBBRAIO Il giardino vero e proprio è il punto di coagulazione della storia, è il suo protagonista; ed è nel giardino che si trova, proprio per questo, l’enorme difficoltà interpretativa. Non farlo vedere, darlo per supposto, è un errore. Farlo vedere e sentire, è un altro errore. Il giardino deve esistere, deve essere qualcosa che si vede e si sente quasi (arrivo a pensare persino all’odore, o solo all’odore, per gioco!), ma non può non essere "un tuffo". Perché il tutto si concentra. Il giardino per me è in "primo piano".
È attraverso il giardino che si vede la storia. È uno schermo attraverso il quale, non deformato, si vede tutto il resto. Nel modo più volgare è un sipario di velo, a giardino, che funge da quarta parete, e si vede e non si vede. Ma, ripeto, questo è un modo volgare per chiarire un punto critico. Ma c’è anche di più. Non basta un piano davanti, occorre qualcosa di più.
È questo "qualcosa di più" che non riesco per ora ad afferrare. Che mi sfugge tra le dita. Anche perché le difficoltà, gli enigmi tecnici mi sono davanti e mi paralizzano quasi del tutto...
11 FEBBRAIO Atto terzo. Il biliardo. Continua l’immagine del biliardo, al centro, per il gioco: rumore di biglie che si toccano, che si deviano, entrano negli angoli, abbattono birilli, vengono riprese, rimesse in gioco. Il biliardo mi risulta come un’altra immagine tipica: l’armadio-mamma del primo e quarto atto.
Esso può essere: il caso, l’azzardo non totale, il senso del gioco della vita, il conflitto, l’urto, lo scambio; e, sul piano realistico-naturalistico, il "biliardo", strumento prediletto e, in un certo senso, manìa-rovina di Gaiev e della famiglia. La famiglia ha giocato, gioca ancora con "la realtà della vita". Spera nel caso, nella felice predisposizione del gioco, nel colpo fortunato, e anche nell’abilità dell’habitué
Non a caso, anche qui Gaiev è un "gran giocatore" di biliardo. Il biliardo è stato scelto a simbolo di altro gioco: troppo comuni le carte, avrebbero potuto anche essere i cavalli e la roulette. Ma forse è più straordinario l’essersi rovinato per il biliardo, o per il biliardo-simbolo. Le carte potrebbero assolvere assai bene anche loro a questo concetto simbolico-veristico, ma hanno una cosa in meno del biliardo: non fanno rumore. Il rumore deve essere fatto dalle parole di chi gioca. Le carte sono il caso silenzioso, unito all’abilità silenziosa. Il biliardo "suona" da solo. Nel silenzio meglio ancora: si sentono le biglie correre, urtarsi, combinarsi, muoversi, sfiorarsi per tornare poi in gioco. Si crea immediatamente una simbologia non visiva ma sonora. Il visivo è dato dall’elemento "giocatore", che punta la stecca e dà il colpo d’avvio, poi aspetta il risultato.
Ma la posizione delle biglie non è risultato della sola abilità. È anche frutto del caso, il modo in cui esse si presentano all’altro giocatore.
Per il Giardino e per Cecov il biliardo è il miglior elemento simbologico che si potesse scegliere. Ed è stato infatti scelto, anche se nel testo è un controcanto, e anche se è tutta da definire la misura della sua presenza, se "da protagonista" o meno, se visiva o puramente sonora, oppure anche – al limite – se puramente affidata ai gesti, alle espressioni di Gaiev.
Qui nasce il primo problema. Il terzo atto è l’atto del presente, della festa, dei giochi, del caso, mentre altrove avviene qualche altra cosa. Gli elementi della festa e del gioco ci sono tutti: il biliardo (ovunque o comunque sia), il ballo con l’orchestra che suona fuori scena, passaggi di quadriglia in scena, i giochi di prestigio di Charlotte, le carte prima e le sparizioni e apparizioni poi, lo spettacolo, il travestimento, l’attore o l’attrice o clown (Charlotte vestita da uomo) ...
Tutto. Il dramma dell’asta e della "perdita della proprietà", del mutamento, del trapasso di poteri e di beni, avviene in questo clima di festa, musica, gioco, figure e rumori e suoi e applausi e danze. Ed è chiaramente ancora il vero plausibile, possibile ed eterno. È possibile dunque scegliere come "centro di focalizzazione" di tutto ciò il biliardo? Non è limitare a un simbolo di realtà del tutto? Sarebbe come mettere al centro l’orchestrina ebraica. O far ballare sempre tutti. O altro.
Purtuttavia, poiché questo "salotto che un arco divide dalla sala" deve avere per forza un suo centro e delle sue parti di appoggio alla recitazione, più ancora che alla situazione, possiamo ipotizzare questa soluzione: "fuori", tutti gli elementi sonori (musica, biliardo, danza, voci, brindisi e altro); "dentro", solo le azioni importanti. Ma ecco che avvengono alcune azioni del gioco anche in scena: il gioco delle carte, lo spettacolo, il travestimento. Dove avvengono? E prima ancora, in che cosa consisteva l’elemento plastico simbolico-realistico del salotto per i personaggi? Ovviamente nelle "cose per sedersi": divano e sedie, oppure poltrone e sedie. Sono queste l’elemento tipico che può dare sostegno all’azione, può significare una "storia", può dare il senso della proprietà in rovina, il metafisico anche della sedia vuota, il tempo o altro. La sedia o poltrona, certo, se sola in scena è un elemento straniante potentissimo: non significa mai solo "sedersi".Più sedie vuote sono "angoscia": incertezza, mistero: chi si sederà? Si sederà mai qualcuno? Cosa aspettano quelle sedie? Chi? Vuote, sono anche solitudine; occupate, possono essere la conversazione, la società raccolta, la gente. Gente che con le sedie può fare tutto: può fare all’amore, o morirci sopra.
Tornando al biliardo, potrebbe trovarsi al centro, con le sedie e le poltrone lungo il perimetro. Non è detto che si debba sempre giocare. Il gioco può aver luogo quando serve. Ma il biliardo potrebbe diventare un piccolo palcoscenico per la rappresentazione di Charlotte, o un punto di sostegno per una conversazione: Lopachin le può usare come un trono, un punto di arrivo, se nel suo delirio vi si arrampica e parla, per poi scenderne sconsolato. Sul biliardo si può anche dormire, se si vuole. Lopachin potrebbe stracciare il panno verde e pronunciare la sua battuta: "Posso pagare tutto, io" ... Gaiev può giocare da solo ...
E l’orchestra, invece, suona invisibile. Essa è l’atmosfera della festa che si interrompe continuamente. Ma anche i giochi negli altri rituali festivi sottolineano in controcanto l’avvenimento decisivo che sta per arrivare.
Qui una festa impossibile, continuamente presente e lontana, continua e interrotta, lo spettacolo, il gioco del biliardo; là il gioco cruento, anche se combattuto ancora all’arma bianca, dell’asta; il gioco, voluttuoso persino, dell’azzardo, del "gioco" capitalistico (che cos’è se non un "incontro", un altro rituale, il "match", quello che poi Lopachin racconta come un cronista patetico, e che è avvenuto nella sala delle aste?). Ad un certo momento il "giocatore" vincitore – Lopachin: la nuova classe che prende il suo posto nella storia, anche se non per molto, l’uomo più nuovo, e più giusto, il più "forte" nell’eterno rifarsi della vita umana – entra in un contatto con l’altro rituale più stanco della festa mancata o che si regge appena. Le parole di Lopachin ("Su, musica, più forza, più ritmo, più allegria...") sono un qualcosa di concreto, come concrete sono le lacrime di Liubov che sconsolatamente piange la sua vita perduta, il suo posto perduto e la sua infanzia, adesso si forse per sempre perduta, definitivamente uccisa.
s. d. (APRILE) ... Soluzione improvvisa. Il dubbio, non mai eliminato, ha avuto ragione: niente biliardo in scena, troppo polivalente (punto d’appoggio, palcoscenico, trono) per essere veramente essenziale. Il biliardo è "di là", a simboleggiare la componente casuale di tutto ciò che – sempre "di là", vicino o lontano – avviene. In scena, solo sedie, ora vuote – con tutto i significati del loro esser vuote – ora occupate ...
1° MARZO Il tempo reale del Giardino non corrisponde sempre al tempo teatrale. Oppure ... è una di quelle indicazioni diabolicamente nascoste del vecchio Anton Pavlovic, quelle che facevano impazzire Stanislawskij. Il primo atto: si apre alle due, alla fine dell’atto siamo a "quasi le tre". Quanto dura l’atto, recitato con il suo ritmo giusto? Quaranta minuti? Troppi.
Io non credo, nonostante la retorica della pausa nelle nostre interpretazioni di Cecov. Oggi però siamo alla retorica inversa. La verità è che Cecov ha un suo ritmo, interno, che è quello che è. Bisogna scoprirlo al di là della lingua, al di là delle abitudini, delle retoriche, dei nostri piaceri. Certo è un ritmo più rilevato di quello che usavamo una volta. È più scorrevole, meno sottolineato, meno "fatalistico". Ma Cecov per fare il "finto vaudeville" non lo si deve recitare come una "pochade"! Non si deve aver paura del silenzio quando occorre. Il primo atto di quaranta minuti. E allora siamo lì, al tempo reale e teatrale unitario.
Il secondo atto: tempo reale e teatrale unitario. Il crepuscolo durata trenta minuti?
Il terzo: durata anche qui reale e teatrale unitaria. Il quarto è sicuro che dovrebbe durare venti minuti o diciannove come dice Cecov. E mette apposta anche l’indicazione. "Tra venti minuti dovete essere in carrozza. Il treno parte tra quarantasei minuti".
Ricordare che Cecov scrive che Costantino faceva durare l’ultimo atto proprio quarantacinque minuti circa e che lui gli dice in chiare lettere che dovrebbe durare diciannove. Un minuto lo lascia perché partano le carrozze! "Incredibile" direbbe Pisc’cik. Il tempo del Giardino corrisponde dunque misteriosamente a un tempo reale. E come tale non deve essere artefatto. Il ritmo dell’ultimo atto appare abbastanza sostenuto ma lascia il suo spazio al silenzio. Bisognerebbe controllare il tempo della dizione russa (lingua) e il tempo di allora, degli attori, non poteva non essere lento, di abitudine.
Da qui probabilmente l’indicazione doppia "vaudeville", per "non lacrimoso" e non "grave alla russa", "lento alla russa". Tutto qui. "Siate più leggeri, più fluidi, più semplici, meno fatalistici, meno drammatici, siate anche più allegri, come nella vita. Vita trasposta ma vita. Come la mia indicazione "tra le lacrime". Io volevo dire solo che tale era lo stato d’animo dentro, del personaggio, non che piange. È un modo di dire convenzionale". Quanti equivoci su questo modo convenzionale, povero Cecov! Certo che quando Cecov scrive che sta preparando una commedia "tutta da ridere" e questa è poi il Giardino dei Ciliegi viene fatto di domandarsi cosa avesse in testa in quel momento ...
Ma riflettere alla fine ironia cecoviana, al suo modo indiretto di dire le cose e fare le sue critiche, forse tutto diventa più facile. Proprio perché Cecov sapeva cosa facevano i "russi", cosa voleva che lui fosse Stanislawskij, cercava di premunirsi con queste affermazioni drastiche.
Mai dimenticare il contesto in cui si svolge il teatro cecoviano.
Ed è qui che tutto diventa ancora più straordinario.
Perché atti come quelli del Giardino sono "inammissibili" nel contesto teatrale mondiale dell’epoca.
Sono l’ultra rivoluzione formale e sostanziale ...
Una rivoluzione a mio avviso non ancora superata. Basta svincolare Cecov dal suo involucro retorico-naturalistico e folcloristico perché egli ci appaia ancora violentemente "al di là" del già fatto e saputo e se si parla di valore "gestuale", anche qui Cecov è sempre avanti. Il materiale gestico e plastico "parla" di per sé. Cecov, entro certi limiti – pare un assurdo – potrebbe essere rappresentato, per "studio", per esercizio mimicamente. Come facciamo del resto, una "lettura" di Cecov, a tavolino.
Tra le due non so quale possa essere immediatamente la più efficace.
Certo, la lettura singola, del regista, in questo caso è la più infelice. Pensiamo un attimo al valore gestuale e visivo-plastico, dell’apertura del quarto atto: la scena, il vassoio con i calici di champagne, l’unica bottiglia falsa, le calosce di Trofimov, l’arrivo dalla quinta di un paio di calosce vecchie e sfondate che cadono con un tonfo sul palco e restano, con una voce in quinta che dice "Tenetevele le vostre schifezze!" o qualcosa del genere. E Trofimov che le prende, le guarda un attimo e le ributta via: "Non sono le mie!".
10 MARZO Il tempo. Problemi del tempo. In questo vaudeville-tragedia-commedia-farsa-dramma, in questo tutto che sempre più mi appare più grande, più perfetto, più denso nella sua chiarità, direi nella sua innocenza. Sto ascoltando Mozart: il quintetto K 516, e penso alla chiarità di Mozart ... così vera e così profonda ...
Il concetto del tempo è fondamentale.
Annoto oggi – per la prima volta, mi pare – un fatto evidente ma al quale non avevo forse riflettuto abbastanza: Liubov è stata via cinque anni. Quando ritorna, Lopachin si domanda: "Mi conoscerà?". E poi ancora: "Chissà come sarà adesso?". Poi Duniascia non viene riconosciuta da lascia. Poi Trofimov non viene riconosciuto da Liubov, e continuamente durante tutto il primo atto i personaggi guardano e parlano di come "le stanze sono rimaste le stesse, il giardino lo stesso", e di come nello stesso tempo le persone sono cambiate tutte o quasi. Anche Firs: "Come è invecchiato!" Liubov dice: "Grazie a Dio, sei ancora vivo!"
È chiaro che il primo fatto è questo: le cose non cambiano, restano immobili, giardini, oggetti, muri e stanze e mobili ... (penso adesso all’inizio, stupendo, di Comisso in "Gioventù che muore", con quella donna che nella neve, nel sole e nell’azzurro sente per la prima volta che quelle cose resteranno così per sempre e lei no, lei diventerà vecchia e morirà: l’estasi della natura immobile, mentre gli uomini passano).
E poi: gli uomini passano in fretta.
Bastano cinque anni per cambiarli tutti. In questo senso i cinque anni all’estero sono una vita. Sembrano più lunghi, soggettivamente ed oggettivamente. I cinque anni non sono solo cinque anni, sono il tempo che passa e modifica.
Di qui il sentimento dell’incertezza, del troppo mutato o del tutto rimasto come prima. Questo atto così sospeso, così incerto, questo passo all’indietro nel passato mentre tutti sono andati avanti nel presente e si proiettano nel futuro ... questo ritorno all’infanzia, nel sonno dell’alba, nella stanchezza dentro e fuori, in questo sfinimento dei nervi troppo tesi per troppa vita e caffè... è davvero "incredibile", come dice Pisc’cik. Incredibile come l’esistenza sulla terra, incredibile come l’esserci e l’andare ... Liubov dice a tutti che sono invecchiati. Mai lo dice di se stessa. Liubov non ha conoscenza del "suo" tempo. Ed è giusto che sia così.
Liubov è l’anima che non cambia, quella che resta sempre così, che forse niente tocca. Ma anche se si resta nel cerchio della "prima scatola", non è difficile conoscere il tempo degli altri; difficile è riconoscere il proprio. Gli altri sono "diversi" da noi. Noi ci ritroviamo "troppo vecchi" o "troppo giovani"; quella realtà temporale che è la nostra, ci sfugge. Forse "deve" sfuggirci, perché altrimenti non ci sopporteremmo. Troppo lancinante è questo cammino ineluttabile nel tempo, questa impossibilità di "capire" il movimento dell’esistenza.
Quanto a Liubov, poi, in particolare, lei forse non vuole nemmeno pensarci, al tempo. Lei non si pone il problema, e anche fisicamente – io credo – Liubov è una di quelle donne incredibili che sembrano ferme con gli occhi spalancati, sulla voragine degli anni, immutabile come bambole di porcellana di cui il tempo si limita a scalfirne appena appena lo smalto ... Liubov – non l’anima: lei donna, come donna – non vede che gli altri. Di sé è cosciente solo in una "fuga verso il passato". Quella nostalgia dell’infanzia perduta e anche di un’innocenza perduta che fanno di lei ancora una volta, come sempre, la verità umana e il simbolo delle nostre misteriose proiezioni nel mondo ancestrale, fino a quell’utero caldo e silenzioso materno che ci ha protetti un tempo e di cui, come essere vivi, sentiremo sempre la nostalgia profonda.
16 MARZO Il secondo atto del Giardino si svolge all’aperto. È l’unico atto che si svolge all’aperto. Ha l’aspetto di un "intermezzo", di una cantata a più voci nel corpo dei quattro atti della storia del giardino. In tutti gli altri atti "succede" qualcosa: o anzi, succede molto. Nel secondo c’è come una stasi dell’azione reale, c’è una specie di immobilità ineluttabile delle figure che "stanno lì", siedono dopo la passeggiata, "aspettano il tramonto", vedono la natura, e parlano, discorrono.
E la vita ovviamente va, come i barchetti al filo dell’acqua, di Montale; anche se i personaggi restano fisicamente immobili, l’azione continua all’interno, anche se l’intrigo è come sospeso, in un arresto attonito, in un ripiegamento su di sé, in una meditazione lirica, dove alcune posizioni gestuali sono sufficienti e vengono appena variate. (L’esempio potrebbe essere di colui che fuma una sigaretta, ripete i gesti soliti di chi fuma, ma fra i tanti che fumano ognuno ripete quei gesti a modo suo, con un proprio tempo, una propria attenzione o disattenzione, una propria voluttà o meno, indifferenza o altro.
Ma il gesto del fumare è uno solo ed uguale nel fondo per tutti). Qui la natura è diventata il palco che ha assunto altre inclinazioni, e il grande tappeto grigio lucente giardino diventa cielo nel fondo, tirato su e srotolato dalla camera dei bambini, dal divano, verso l’alto. Attraverso una grande lacerazione antica del tappeto-cielo-giardino, il plastico della città che cresce e il trenino magico che passa all’orizzonte. Il trenino poi ripasserà sul davanti, davanti ai personaggi che lo fisseranno e lo sentiranno fischiare nella sua reale irrealtà di vita vera e gioco infantile e gioco di palcoscenico. Il secondo tempo sarà animato da questi passaggi ...
E qui andrà eliminata tutta la simbologia segnata da Cecov: la cappella cadente, le pietre tombali, i simboli di un mondo che sta in bilico, di cose morte, di una verità che vacilla, del passato sepolto, del domani che cresce (la città e i pali del telegrafo), della civiltà industriale che viene avanti, sempre più avanti ...
Ho sempre pensato che questa simbologia fosse un retaggio di gusto incerto, una pericolosa tendenza al simbolismo che Cecov quasi sempre evita con una straordinaria abilità. (Anche qui, all’atto pratico della rappresentazione, Cecov sembra fare macchina indietro sulle proprie stesse didascalie: lettera a Nemirovic-Dancenko del 23 ottobre 1903: "Nel second’atto non c’è nessun cimitero"!). È una simbologia che non può arrivare al pubblico con la forza diretta con la quale arrivano la simbologia della camera dei bambini, del salone della festa, dell’ammucchiarsi dei mobili dell’ultimo atto, delle valigie della partenza nella scena vuota con poca roba ammucchiata. Perché tutte queste sono le simbologie che nascono da una realtà plausibile non composta, mentre quella del secondo atto può essere plausibile ma è troppo "ben composta" ad arte per non apparire artificiosa. Non c’è bisogno di questa simbologia totale: basta la simbologia diretta della città che cresce e del treno che passa: di quel treno che Cecov non voleva che passasse; o, meglio, di cui poco gli importava. (Altra lettera: a Stanislawskij, 23 novembre 1903: "Se il treno si mostrasse senza rumore, senza alcun suono, allora fatelo passare").
A Cecov bastano i silenziosi pali del telegrafo e le ciminiere della città nella nebbia del fondo per dire che un mondo nuovo sta sorgendo lì presso; che gli bastano i personaggi per dire che un mondo vecchio muore. Ma se noi faremo correre quel trenino non sarà per memoria di stanislawskij ma per immettere sempre il doppio tema dell’infanzia perduta e del gioco in una doppia prospettiva: il treno lontano che passa nel fondo può essere, è un qualcosa di vero; davanti, è un giocattolo che fugge, fugge traballando sulle sue piccole finte rotaie. È qui, nel second’atto, che per la prima volta si verifica quel "rumore" famoso della corda spezzata; problema sul quale tutti i registi del mondo si sono spezzati le corna. Non credo che la soluzione demistificatoria di qualche regista attuale (un piccolo suono di gong per cambiare "atmosfera") sia la soluzione giusta.
Meglio allora, coraggiosamente, nulla. E perché no? Perché questo suono-simbolo non potrebbe essere qualcosa che i personaggi nel crepuscolo sentono: sentono "loro", ma non noi, pubblico che guarda?
Lo so che questo è forse un semplificare o un girare attorno al problema (o meglio, così potrebbe forse apparire), ma probabilmente quel suono proprio non si deve sentire! Deve restare indeterminato, descritto da ciò che dicono gli attori-personaggi. Non è una soluzione di comodo. Solo che ecco: il treno che passa improvvisamente si ferma, e forse deraglia "in quel momento", e le ruote del giocattolo-mostro girano a vuoto nell’aria con un rumore di sfere e di molle che si scaricano freneticamente. Poi qualcuno rimette tutto al suo posto, la macchina di nuovo carica, il trenino riprende ad andare e sparisce traballando in quinta per poi riapparire sul fondo come prima.
Ogni personaggio-attore avrà un sussulto, e tutti guarderanno e tenderanno le orecchie in varie direzioni, anche opposte tra loro. Uno verrà alla ribalta, scenderà magari verso il pubblico cercando il "suono" nella platea, interrogando la platea con lo sguardo e con un piccolo gesto della mano. Ma nessuno riuscirà ad individuare il "punto" da cui il suono "interiore" è partito. Quel suono è un brivido della storia, al quale i personaggi danno la più banale delle spiegazioni possibili. Unica Liubov, che dice: "Non so perché, ma non mi piace". Il brivido della storia non lo si simboleggia né lo si oggettivizza con un suono. Neanche con il marchingegno di Stanislawskij e Dancenko. Oggi, fino a prova contraria, io credo che quel famoso suono sia un’illusione letteraria, un sedimento di scrittura per evocare un fatto sonoro, e che ha l’aspetto di una teatralità oggettiva. E questa ce l’ha per certo: sembra fatto apposta per dare uno scatto ritmico al finale dell’ultimo atto, ad esempio. Ma appunto lì si demistifica come tale: è cioè un espediente in più. Io credo che nessuno possa rifiutare l’idea che lo stesso suono inteso al secondo atto, ripetuto nell’ultimo atto a scena vuota, con Firs immobile, nella sua reale-apparente morte, sia non necessario, e che sia anzi di troppo.
Tanto più che insieme a quel suono ci sono anche i famosi colpi di scure sui ciliegi. Così, io penso che questo suono non lo realizzerò con un "suono", ma con un "suono silenzioso" più sonoro di un colpo di lama o di fucile. Il punto è qui.
21 MARZO Il giardino si è precisato in immagine. Quel giardino che ci deve essere e non essere, che deve stare davanti e che a gennaio era una sensazione, ora sta diventando qualcosa. Luciano ha proposto una "cosa in alto" che investe gli spettatori, ma "da sopra". Su questa idea, non ancora immagine, abbiamo lavorato e siamo giunti alla decisione di tentare il "giardino" come una "cupola" lieve, di stoffa, non velo ma altro, che può palpitare, che è trasparente, che sale sopra la platea, in luce e movimento e colore e che si proietta nella scena come un soffitto ideale che prolunga quello invisibile di una casa. L’immagine non è ancora chiara, solo la prova reale ci potrà dare la misura del suo valore evocativo-plastico-poetico.
Io credo che questa apparenza non simbolica, poiché si tratta di qualcosa di reale, questa luce-atmosfera che varia negli atti, questo palpitare di un cielo teatrale, con fogli di carta sottile che frusciano con un suono "trasposto" e altri effetti imprevedibili possono dare concretamente questo incredibile giardino di Cecov meglio di ogni altro fatto teatrale o di una sua assenza per finto amore di "castità" o "nudità". Ma non solo, la scena stessa è arrivata a definire quello spazio bianco che Cecov ipotizzava nella sua lettera del 5 ottobre da Yalta. In questa lettera c’è una incredibile concentrazione di "tempo", egli parla di un giardino estivo bianco, tutto bianco anzi totalmente bianco e di signore vestite di bianco. Dopo un attimo aggiunge "Fuori nevica". Straordinaria questa doppia immagine, estate-inverno, collegata sul bianco totale. Questo eterno bianco di giardino sotto i fiori bianchi della primavera e sotto la neve dell’inverno. Così mi appare certo che il Giardino dei Ciliegi è nato per Cecov in un lancinante bagliore di bianco, è un bianco "senza stagione".
5 APRILE Spessore sociale nel Giardino. L’arco dei personaggi del Giardino, risente dal punto di vista "sociologico" di alcune "manchevolezze"? È una domanda che viene da farsi quando si esamina il testo sotto il profilo della "seconda scatola", quella della storia.
Chiaro appare che della "storia" non ci possono essere tutti gli emblemi o meglio i "casi tipici". È un errore molto diffuso quello innanzitutto di pensare al "tipico" come al "positivo" almeno ad un certo grado di positivo e nello stesso tempo di pensare il "tipico" come assoluto, cioè come "totalità" assoluta, astratta di una realtà sociale. Il "tipico" è invece una "relativa potenzialità" della realtà così come è, anch’essa nel suo tipico. Direi che il "tipico" è la massima potenzialità di tipico consentito dal contesto storico e dalla necessità poetica. Innanzitutto sul versante storico, nella realtà storica, non esiste "la persona" che realizza in sé stessa come tale la rappresentazione di tutte le contraddizioni del suo momento. Tale realtà è data da "tutti" coloro che vivono la verità della storia in un certo punto del suo muoversi, cioè la realtà tipica è la somma di tante realtà pure tipiche ma parziali e diverse tra loro anche, a diversi gradi. La tipicità e la massa. Le masse sono tipiche. Gli uomini singoli lo possono essere ma relativamente.
Secondo: il tipico ha le contraddizioni "tipiche" che gli appartengono.
Terzo: esiste la volontà e la necessità di chi scrive, della scelta della sua storia, del suo soggetto, del suo svolgersi di una storia. Così nel Giardino la scelta operata da Cecov nel "suo mondo", nella sua storia è certamente uno dei più alti esempi di tipicità-emblematicità-realtà possibili ma è certamente anche una esclusione: esisteva, ad esempio, un proletariato più o meno cosciente, nel suo momento storico, nel momento del Giardino? Esisteva "un rivoluzionario", più fermo e sicuro dell’eterno studente? Esisteva un "reazionario" più cupo e più sordo di Gaiev e Liubov? E così via. Certamente sì. Ma la tipizzazione di Cecov è ugualmente enorme, nell’ambito del mondo o di quella parte di mondo da lui scelto per raccontare la sua storia. Gorki ne sceglieva un altro e del pari ne escludeva una parte. Cecov sceglie come "punto ideale" d’incontro una proprietà terriera. Poteva scegliere una "proprietà industriale".
Ecco una prima scelta. Ma proprio scegliere la "proprietà agricola-terriera" è nello stesso tempo vincolante, parziale e altamente tipico, poiché in quel momento storico, in quel paese, il problema della proprietà unito al problema della terra, è fondamentale. È uno dei più vasti campi delle forze in conflitto.
La Russia senza il problema fondamentale della "terra" non sarebbe la Russia; senza il problema delle "comunicazioni", della "steppa" piatta e infinita di Cecov, sarebbe un’altra. Cecov conosceva bene questa parte della realtà, questa enorme parte della realtà ed a questa si applicò, direi, automaticamente. Diceva Cecov: "Ognuno scrive come può e come sa". È in quel sapere che si nasconde la differenza fondamentale tra i "naturalisti" e i realisti. Qui esiste perfettamente ancora la teoria di Lukàcs tra narrare e descrivere. Chi sa narra, chi non sa o sa per "acquisizione esteriore" descrive. E Cecov narra sempre.
Dunque la proprietà, e nella proprietà una casa e un giardino. Di questa casa e di questo giardino, coloro che vi abitano o vi passano. Il giardino diventa il luogo di incontro-scelta di una parte della società. Un’altra parte ne è tagliata fuori. Ma quella che resta è importantissima, ha tutti i caratteri di una tipicità storica e umana, limitata purtuttavia.
Ed è qui che bisogna stare attenti, qui bisogna affermare con coraggio che più in là di "questa" Cecov non poteva e non doveva andare.
Perché solo fino a là Cecov sapeva.
Cecov insomma non poteva forse sapere molto di più sul versante del futuro di quello che sa il vecchio studente, e dall’altra parte, sul versante del passato, quello che lascia intravvedere il vecchio schiavo Firs.
Tra questi due poli, in una prospettiva incredibilmente esatta, tutti gli altri uomini e donne.
Con i suoi vuoti, che "altre" commedie, altre novelle di Cecov riempiranno fino ad un certo punto.