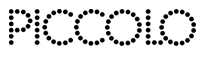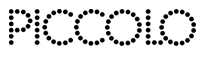Note sparse sulla terza edizione dello spettacolo I giganti della montagna
I giganti vincono sempre I giganti perdono sempre Cè un tema profondo, ricorrente nella grande cultura greca-europea il tema dei Giganti mitici che vogliono impadronirsi del potere celeste, universale. E vengono sconfitti, quando sembrano avere vinto.
Questo tema dei Giganti è profondamente radicato nel cuore europeo. Pirandello nella sua ultima opera incompiuta lo esemplifica con il Teatro e la Poesia, lo innesta in una problematica che prende laspetto della Rappresentazione.
Due mondi: gli Scalognati, fuori della realtà perché si credono altri di quelli che sono e perché la "società normale" non li vuole. I Comici, fuori della realtà perché "attori" e perché la realtà del pubblico non vuole accettare il loro messaggio, lopera poetica che recitano. I due mondi si incontrano in una villa metafisica, un luogo non luogo, dove realtà e sogno si confondono. Ma ad Ilse, lAttrice che brucia di teatro, non basta. Il Teatro e la sua Poesia devono essere dati al Mondo della Realtà. Non restare sogno. E fuori dal Sogno ormai la Realtà è quella dei Giganti e dei loro servitori, gente che si è ottusa, che ha dimenticato il cuore, la bellezza. Gente che lavora per costruire cosa, scavare, consumare. Ilse con il suo tragico e meraviglioso errore, obbliga la sua Compagnia, il Teatro, a recitare proprio là, davanti a Giganti invisibili e presenti. Crotone, il Mago del Sogno, avverte però che "là", egli non può salvare Ilse. Ed Ilse viene uccisa dal pubblico dei piccoli Giganti (i grandi forse sono altrove, forse non sanno nemmeno più che il teatro esiste) che sentono la Poesia come una provocazione. I Comici se ne vanno con Ilse morta affranti ma anche liberati.
Nellepoca dei Giganti è "umano" adeguarsi, non dare più messaggi, restare dei pagliacci che fanno ridere e niente altro. Il corteo funebre nella platea non può non segnare che una sconfitta ed un’accusa. Il Piccolo Teatro rappresenta nellanno 1994 per la terza volta una nuova edizione dei Giganti della montagna di Pirandello.
La prima ha avuto luogo nel 1947: come un presentimento.
La seconda nel 1966: come un timore che nonostante tanta "rivoluzione" giovanile intorno, il cammino della società degli uomini verso labbandono di alti ideali e valori, fosse accelerato e quasi ineluttabile.
La terza, questa: come una tragica contestazione che i Giganti hanno vinto e che ci hanno, consapevoli o inconsapevoli, travolti, che non siamo più gli stessi, che stiamo precipitando.
Noi siamo, oggi, diventati anche noi, figli e servi dei Giganti misteriosi che guidano la nostra vita in un crepuscolo dellanima sempre più universale. La metafora del Teatro e della Poesia è diventata qualcosa di più. Davanti al pubblico di oggi, noi attori, come quelli della Favola davanti al pubblico dei Giganti, dobbiamo soltanto sparire e lasciare un vuoto e un alto silenzio.
Forse è proprio da questo ultimo sacrificio, dal brivido degli spettatori, lasciati soli in un teatro semi buio dalle povere luci vacillanti che può nascere un sussulto, una domanda, un breve ma profondo ripensamento sul nostro destino umano. Non si tratta di "rifare" per chissà quale inesistente comodità, uno spettacolo di un lontano passato. Ma di riaffermare, ancora più tragicamente di sempre con uno spettacolo di oggi, il grande smarrimento che ci circonda. Una sola speranza: i Giganti hanno vinto sempre. E sempre hanno perso, nel mito e nella storia. Luomo non si è ancora definitivamente perduto. I giganti della montagna rappresentano nel "mio" teatro un antico amore. Il copione, dalle pagine leggere e gualcite, dove ritrovo segni misteriosi, indicazioni di cui non rintraccio più il senso, il frego rosso dei sipari indicato dal suggeritore, porta il numero 5 sulla copertina. Il che mi ricorda che è stato, nel 1947, il quinto spettacolo del Piccolo Teatro.
Tra quel numero e oggi: una vita, una storia intera di teatro.
Ritornare a questo testo, quasi alla fine di una parabola, mentre si addensano dentro e fuori di me, nuovi temi, nuove urgenze, lampeggiamenti di perplessità, e anche ineluttabili chiarezze, può sembrare soltanto un’attitudine della memoria, un gesto affettuoso verso se stessi, verso una disperata coerenza in un mondo che si sfalda, si contraddice, si rinnega ad ogni attimo. Ma non lo è.
O, almeno, lo è solo in parte, da un punto di vista più segreto ed affettivo.
Altre volte, dopo di allora, mi sono trovato a confrontarmi con attori anche stranieri, con il tema dei giganti. E ogni volta sono stato mosso dal tentativo di entrare più profondamente dentro quest’opera misteriosa, come sono misteriose tutte le opere ultime dei Grandi Vecchi, lasciate come un riassunto - che è al tempo stesso un’apertura per il domani - dai drammaturghi - poeti al limite della loro vita.
E’ straordinaria la carica "magica" che le tempeste dei drammaturghi poeti, portano dentro, nel tempo. Una specie d’irradiazione, di cui non si sa spiegare la natura, pervade certe pagine dell’ultimo teatro dei grandi drammaturghi alle soglie della morte o della follia: succede a I giganti della montagna, rimasti addirittura incompiuti eppure perfettamente compiuti nella loro parabola.
Un testo nel quale l’ultima parola scritta è una battuta d’angoscia gridata dai comici: "ho paura", al precipitare dei giganti in marcia al di là delle precarie mura della Villa della Scalogna. Nel ricreare, oggi, questo testo ho tentato per prima cosa, di lasciare ai Giganti il suo limite di mistero da non violare: un barlume, un lampo abbacinato, un suono teso. Ma non un incubo mitteleuropeo, come forse verrebbe fatto di pensare e come, del resto, io stesso ho lasciato talvolta che avvenisse. Semmai un lucido sogno metafisico, tutto nostro, italico, con il suo fondo di favola popolare, di credenze antiche, che diventa anche, talvolta, favola, mito. Qui si tratta del mito ultimo, quello della poesia, meglio ancora dell’arte, in assoluto.
E per Pirandello è il teatro che incarna la poesia, il mistero dell’arte, meglio che ogni altra "forma". Da qui l’avventura dei Comici e degli Scalognati.
Ma chi sono gli Scalognati se non l’incarnazione di un altro modo di fare teatro, più puro: perché se stessi?
Un nano che vuole credersi bambino, una vecchina che vuole credersi morta, una donna cannone che vuole credersi leggera come una ballerina sul filo, un mago che vuole credersi mago, un vecchio mendicante che a forza di tendere la mano, di essere respinto, si ritrova insieme agli altri, ai margini della vita.
E i comici che recitano per gli altri più che per se stessi, a forza di recitare una favola che nessun pubblico vuole accettare, trascinati da Ilse, "attrice" assoluta, anch’essi finiscono per essere "dimessi" dalla realtà, per trovarsi "fuori" della vita, ai piedi dell’immaginaria o reale - come si vuole - Villa della Scalogna, dove vivono Cotrone ed i suoi Scalognati. Due mondi che entrano in contatto in un’aura sospesa dove ogni cosa è possibile.
Siamo nell’assoluto, tutto qui si pacifica, tutto si accetta, tutto è creduto, tutto è valido e vero.
Qui i comici potranno recitare la loro favola ed essere capiti. Addirittura nasceranno dal nulla, diretta invenzione del poeta, i personaggi mancanti e ormai non più recitati dalla piccola compagnia, dai resti, dice un comico, di quella che fu una gran compagnia.
E’ a questo punto che avviene il gesto definitivo di Ilse. Forse nella drammaturgia della "rappresentazione" o del "teatro nel teatro" di Pirandello, il dramma più "teatrale" di tutti è I giganti della montagna. Mito dell’arte che si rappresenta simbolicamente nel "teatro", nel testo di teatro-poesia, negli attori che lo "rappresentano", nel pubblico che non laccetta o l’accetta con tentennamenti. Mito dell’arte che si rappresenta simbolicamente nella fantasia degli Scalognati. Fantasia che si realizza nella volontà o capacità tenacissima di "inventarsi" una situazione teatrale quasi solo per sé. Gli altri non devono "divertirsi", capire o altro, basterebbe che "accettassero la fantasia-follia".
Teatro degli Scalognati perché questi ultimi non devono abdicare alla vita e vivere il loro teatro pensato, inventato, anche in mezzo agli altri.
Gli Scalognati tra di loro si accettano, accettano il teatro di ciascuno (il nano che dice di essere bambino, la vecchina che dice di essere morta sono degli esempi precisi).Arrivano gli attori. Ilse incomincia a recitare la Favola del figlio cambiato davanti agli Scalognati, come in un delirio. Gli attori aiutano la recita di Ilse che s’interrompe subito.
E subito questi attori, come su di un palcoscenico, davanti agli Scalognati, gridano la loro passione (il loro teatro privato, la loro vita privata, gli amori, le pene, i rimorsi, persino le loro storie private), recitano impudicamente il loro dramma (come in un certo senso potevano farlo i Sei personaggi di fronte agli attori ignari). Ostentano, insomma, il proprio dramma davanti ad altri. Non è anche questo fare "teatro"?
Poi gli Scalognati recitano il loro "teatro" per gli attori: la vecchina racconta la sua morte, Duccio, in parte la sua storia, Cotrone quasi tutta la sua, il nano Quaqueo balla sui tasti dell’organo come un gatto. Poi i comici riappaiono vestiti "da teatro";, con costumi teatrali che hanno indossato quasi senza saperlo, cioè non con la "coscienza" degli attori professionisti.
E quasi s’incantano e si meravigliano di averlo fatto, di questo mascheramento di teatro. In un secondo momento l’arsenale delle apparizioni è un teatro in formazione, dove si accumulano le "apparizioni" di teatro in genere, in particolare i fantocci della Favola del figlio cambiato.
Qui entrano, come in un sogno, Ilse e il Conte e rappresentano involontariamente e inconsciamente una parete del loro dramma di reciproca incomprensione, con implicazioni sentimentali e persino sessuali, davanti ai fantocci immobili. Dopo di loro entrano, come in trance, Diamante e Cromo, trasformati in due personaggi diversi della Favola del figlio cambiato dai due diversi costumi che indossano.
Entra Battaglia, vestito da donna, da sgualdrinella. I Fantocci e i sogni dei comici si mescolano in una rappresentazione teatrale parafrasando il ballo del caffè della Favola. Spizzi, in sogno, s’impicca davanti ai sogni dei compagni e ai fantocci. E come una specie di prova generale della Favola del figlio cambiato e, dove i personaggi mancanti della rappresentazione nascono dal nulla.
Questa prova generale ha il suo doppio nell’epilogo senza parole nel quale i comici recitano davanti ai Giganti e Ilse viene uccisa, sul quale s’innesta un’altra rappresentazione, nella quale i comici "recitano" il dramma del loro dolore e il funerale di Ilse. Il finale di I giganti della montagna, è un vero e proprio prisma di situazioni teatrali, uno spasimo di teatralità.
Un "tutto teatro", un tutto recita teatrale. Gli uni per gli altri.
Come farlo sentire al pubblico contemporaneo? Come, al di là delle parole che non esistono, "comunicare" in silenzio la reciprocità delle sconfitte?
I comici dovrebbero far vedere oltre la tenerezza degli oggetti, del trucco, l’amore delle cose, la pena dei costumi vecchi, del mascherarsi ogni sera, del portare avanti, penosamente, una "missione" senza quasi saperne il perché. Ma anche la testardaggine imposta o subita, quel tanto di egotismo di sentirsi i fulcri del mondo. Per Ilse la capacità di riformare il mondo con il suo dire poesia, ecc.
I giganti non si vedono, ma condizionano i servi che assistono alla rappresentazione, ma che non capiscono e che, a loro volta, fisicamente non si vedono, perché, per Pirandello, stanno "al di là del tendone"?
Gli Scalognati: che sono impotenti e non muovono un dito, non possono "farlo" nella vita?
Ma senza caricare di troppi significati l’azione muta finale, che è la peggior cosa.